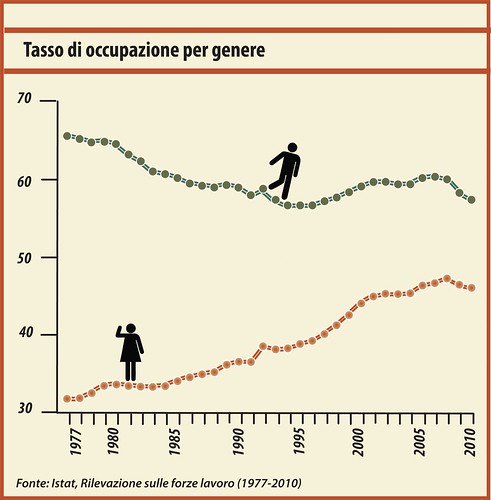Si accentua la distanza tra i redditi. Solo per il Fisco persi duemila euro
articolo tratto da contro la Crisi.org
ROMA — Le retribuzioni dei lavoratori italiani sono basse e tartassate. Negli ultimi 15 anni hanno perso terreno nei confronti internazionali. E la differenza tra i salari più ricchi e quelli più poveri è aumentata. Adesso, poi, con l'inflazione che ha ripreso a correre e con la stangata Monti appena decisa, la perdita di potere d'acquisto rischia di essere pesante.
Partiamo dai raffronti con gli altri Paesi, utilizzando i dati 2010 dell'Ocse, l'organizzazione dei Paesi più industrializzati. L'Italia si colloca al 22esimo posto su 34 nella classifica dei salari netti: 25.155 dollari (19.350 euro al cambio di ieri). Mille euro in meno della media Ocse e quasi 4 mila in meno della media dell'Ue a 15. Nel Regno Unito la retribuzione netta è stata di 11 mila euro superiore a quella media italiana. In Germania hanno preso quasi 5 mila euro in più che da noi, in Francia 2 mila e perfino in Spagna ci hanno superato di circa 1.500 euro. L'Italia è comunque ultima per livello di salario netto tra i Paesi del G7. Volete una spiegazione? Ce ne sono tante, ma una la fornisce la stessa Ocse, mettendo a confronto il livello di imposizione fiscale (tasse e contributi) sugli stipendi. L'Italia si colloca al quinto posto su 34, con un prelievo del 46,9% misurato sulla retribuzione media di un lavoratore single senza figli. Ci battono, nell'ordine, solo Belgio (55,4%), Francia (49,3%), Germania (49,1%) e Austria (47,9%). Invece, Spagna, Olanda e Danimarca stanno intorno al 38-39% e il Regno Unito al 32,7%. Se poi si mettesse a confronto il prelievo su un lavoratore con carichi familiari è probabile che la posizione dell'Italia peggiorerebbe, per esempio rispetto alla Francia che ha il Fisco col quoziente familiare.
Questa la fotografia attuale, ma la cosa che preoccupa di più, osserva Carlo Dell'Aringa, uno dei massimi esperti della materia, è che «negli ultimi 10-15 anni la posizione relativa dell'Italia è peggiorata. È aumentato cioè il divario rispetto a Regno Unito, Germania, Francia e Olanda. Il motivo è che la produttività è rimasta quasi ferma, mentre altrove è aumentata». Dal '96 a oggi le retribuzioni lorde sono rimaste al palo. Scrive la Banca d'Italia nell'ultima relazione annuale: «Nel settore privato tra il 1996 e il 2010 le retribuzioni reali di fatto per unità di lavoro sono aumentate dello 0,7% all'anno, quelle contrattuali dello 0,4%». Ma nell'ultimo anno è venuta meno anche la tenuta rispetto all'inflazione ufficiale. Gli ultimi dati dell'Istat, riferiti al terzo trimestre del 2011 segnalano che nei confronti dello stesso periodo del 2010 le retribuzioni lorde sono aumentate dell'1,4%, cioè meno della metà rispetto ai prezzi (l'inflazione ha raggiunto il 3,3% a novembre). Inoltre, secondo l'Ires-Cgil guidato da Agostino Megale, ilfiscal drag , cioè le maggiori imposte che si pagano per effetto dell'aumento nominale dei redditi, ha sottratto ai salari lordi più di 200 euro all'anno dal 2000 al 2010. E nel 2011, secondo l'Ires, uno stipendio medio perderà circa 260 euro di potere d'acquisto rispetto all'inflazione e 306 euro a causa del fiscal drag : in tutto 566 euro.
L'inflazione e il cosiddetto cuneo fiscale, dunque, hanno un peso nel far perdere terreno ai salari, già tradizionalmente bassi in Italia, a causa della struttura produttiva dominata dalle piccole e piccolissime imprese. Sempre l'Istat osserva che «i lavoratori dipendenti delle microimprese (meno di 10 addetti) percepiscono una retribuzione annua pro capite di 18,4 mila euro, il 65,6% di quella percepita in media dai dipendenti delle imprese con 250 addetti e oltre (28,1 mila euro). Il differenziale retributivo medio legato alla dimensione aziendale è riscontrabile in tutti i macrosettori di attività economica». Le imprese con più di 250 dipendenti sono appena 3.502 su un totale di 4,3 milioni. Quelle con meno di 10 addetti 4,1 milioni. La dimensione media delle aziende italiane è di 3,9 addetti. Il valore aggiunto pro capite nelle microaziende è di 24 mila euro, in quelle con più di 250 dipendenti è invece di 60 mila euro. Eccolo il legame tra salari e produttività.
A questa situazione di base, già svantaggiata, si somma una scarsa crescita della produttività, in parte riconducibile proprio al nanismo imprenditoriale, in parte ad altri fattori. Spiega Dell'Aringa: «Il basso andamento dei salari riflette a posteriori la dinamica della produttività. Si tratterebbe invece di legare retribuzioni e produttività ex ante, attraverso una contrattazione più efficiente. In altre parole, se i lavoratori, azienda per azienda, sanno che producendo di più guadagneranno di più, questo può innescare un comportamento virtuoso che farà crescere la produttività e quindi i salari». È un po' quello che è successo in Germania e negli altri Paesi dove la contrattazione aziendale è sviluppata e c'è una maggiore partecipazione dei dipendenti ai risultati dell'impresa. Ci sono poi almeno altri due fattori che svantaggiano l'Italia nei confronti internazionali. 1) I maggiori costi dei servizi pubblici e privati alle imprese: dai trasporti alla giustizia, dall'elettricità alla burocrazia. 2) Un livello di istruzione della manodopera inferiore alla media dei Paesi Ocse e con una formazione spesso non in linea con le richieste delle imprese.
Per rimettere in moto la produttività bisogna quindi agire su più fronti, attraverso riforme strutturali, accompagnate da una contrattazione più moderna e partecipativa. Più produttività significa più salario. A patto però che il prelievo fiscale e contributivo non aumenti e che l'inflazione venga tenuta sotto controllo. Questo per la media dei lavoratori. Ma c'è un'emergenza che riguarda i precari e più in generale i poor workers , quelli con retribuzioni povere e instabili che si allontanano sempre più dai lavoratori più ricchi. Il salario medio del 10% più ricco nel nostro Paese, dice l'Ocse, è oltre 10 volte quello del 10% più povero: 49.300 euro contro 4.877, e il divario è aumentato rispetto agli anni Novanta, quando era di 8 a 1.
Secondo il 12° Rapporto sulle retribuzioni in Italia 2011 di OD&M, effettuato elaborando le retribuzioni di un campione di 700 mila lavoratori, i dirigenti guadagno in media 106.886 euro lordi, i quadri 53.585, gli impiegati 27.009, gli operai 21.793. E, «con riferimento ai primi 6 mesi del 2011, solo i dirigenti hanno avuto un aumento del proprio potere d'acquisto».
Il problema dei poor workers, dice Dell'Aringa, va affrontato con decisione, facendo costare di più determinate forme di rapporto di lavoro abusate dalle aziende: «Mi riferisco alle false partite Iva, alle false collaborazioni e ai falsi stage. Bisogna aumentare i contributi sui lavori precari con un unico committente e forse bisogna pensare a un salario minimo. Eppoi, si devono mandare anche i carabinieri». Solo così le aziende non troveranno più conveniente mascherare dietro rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione quelli che sono invece lavoratori subordinati a tutti gli effetti. Eliminati gli abusi, bisogna «non toccare forme contrattuali che funzionano, come l'apprendistato, il lavoro interinale e i contratti a termine, che hanno tutte le garanzie del caso e spesso sono un trampolino verso i contratti a tempo indeterminato». Per questi ultimi, conclude Dell'Aringa, bisogna rilanciare la produttività, ridurre la differenza tra lordo e netto, tagliare quindi il cuneo fiscale e gli altri costi. Tra questi ultimi ci sono anche quelli dei licenziamenti. Ma tagliarli non è il toccasana